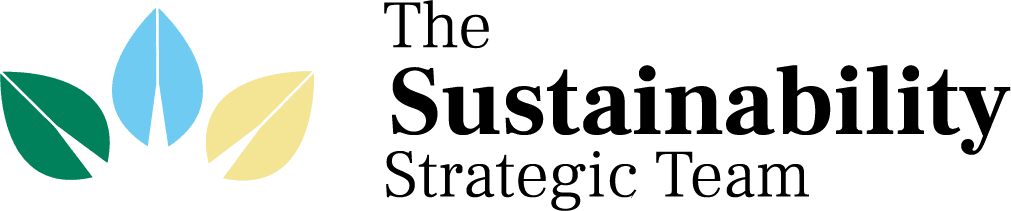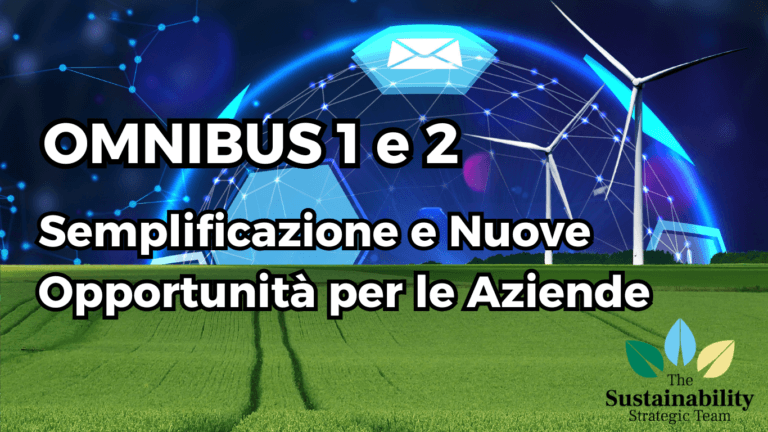la nuova cooperazione energetica europea
Climate-Security Nexus
Quando il Cambiamento Climatico Diventa Questione di Sicurezza Nazionale: il Nuovo Patto per il Mediterraneo come laboratorio della convergenza tra crisi climatica, instabilità geopolitica e cooperazione energetica
L’integrazione esplicita del Climate-Security Nexus nella strategia europea rappresenta molto più di un semplice aggiornamento terminologico o di un’aggiunta settoriale alle politiche climatiche tradizionali. Rappresenta un salto concettuale fondamentale nel modo in cui le istituzioni europee, e gradualmente anche quelle di altri Paesi e organizzazioni internazionali, comprendono e affrontano il cambiamento climatico.
Non si tratta più di considerare il clima semplicemente come una questione ambientale settoriale da gestire attraverso politiche di mitigazione e adattamento, ma di riconoscerlo come un moltiplicatore sistemico di minacce che interagisce in modo complesso e spesso imprevedibile con vulnerabilità sociali preesistenti, fragilità istituzionali croniche, competizione per risorse sempre più scarse, migrazioni forzate su larga scala e conflitti armati.
Climate-Security Nexus: Dal Dibattito Accademico alla Realtà Operativa
Questa prospettiva, che affonda le sue radici intellettuali nel dibattito accademico sulla sicurezza umana e ambientale sviluppatosi negli anni Novanta, è ora pienamente integrata nelle analisi di intelligence prodotte dai servizi di sicurezza dei principali Paesi, nella pianificazione strategica militare delle forze armate, nelle valutazioni di rischio delle grandi istituzioni finanziarie internazionali, e nelle policies concrete delle organizzazioni multilaterali.
La Base Empirica: Quando i Dati Confermano l’Intuizione
L’evidenza scientifica ed empirica che supporta la convergenza tra clima e sicurezza è ormai solida, robusta e difficilmente contestabile anche dai più scettici. La ricerca quantitativa in questo campo, che inizialmente era considerata metodologicamente problematica e poco rigorosa, ha prodotto negli ultimi quindici anni risultati sorprendentemente consistenti attraverso diverse metodologie, scale geografiche e periodi temporali.
Un dato particolarmente eloquente emerge dall’analisi della sovrapposizione tra vulnerabilità climatica e conflitto armato: dei venti Paesi identificati come più vulnerabili e meno preparati ad affrontare il cambiamento climatico, ben dodici si trovavano in situazioni di conflitto aperto nel 2020. Questa correlazione, sottoposta a rigorosi test statistici, conferma che non può essere liquidata come semplice coincidenza.
Il Legame Quantificabile tra Temperatura e Violenza
Studi econometrici sofisticati hanno quantificato la relazione tra anomalie climatiche e diverse forme di violenza. Un risultato particolarmente robusto indica che un aumento di un grado centigrado della temperatura media è associato a:
- Incremento della violenza interpersonale dell’ordine del 2%
- Incremento dei conflitti intergruppo tra il 2,5% e il 5%
Climate-Security Nexus: Le Proiezioni per il Futuro
Le prospettive sono ancora più preoccupanti. Entro il 2050, secondo stime convergenti da diversi modelli climatici e idrologici, oltre un miliardo di persone potrebbe trovarsi in condizioni di stress idrico severo, definito come situazione in cui la disponibilità annuale di acqua rinnovabile per persona scende sotto la soglia critica di cinquecento metri cubi.
Questa pressione idrica si traduce inevitabilmente in tensioni sociali acute, in movimenti migratori sia interni che transfrontalieri, e in competizione potenzialmente violenta per risorse idriche sempre più scarse, particolarmente in regioni dove l’acqua è già condivisa tra molteplici utenti e Paesi attraverso bacini idrografici transnazionali.
Climate-Security Nexus: Come il Clima Si Traduce in Conflitto
La relazione tra clima e sicurezza non è deterministica nel senso che anomalie climatiche causano automaticamente e inevitabilmente conflitti armati. È invece probabilistica e opera attraverso catene causali complesse e mediate che coinvolgono variabili economiche, sociali, politiche e istituzionali.
La Catena Causale in Cinque Anelli
Primo anello – Impatto sulla produzione agricola: Eventi climatici estremi come siccità prolungate, inondazioni devastanti, o ondate di calore eccezionali hanno un impatto immediato e tangibile sulla produzione agricola. Questo impatto è particolarmente severo in Paesi dove l’agricoltura rappresenta ancora una quota significativa dell’economia nazionale e dove una larga parte della popolazione dipende direttamente dall’agricoltura di sussistenza.
Secondo anello – Pressioni economiche acute: Quando i raccolti falliscono, i redditi rurali diminuiscono drasticamente mentre i prezzi dei beni alimentari di prima necessità aumentano significativamente. Il risultato è un rapido deterioramento delle condizioni di vita, un aumento della malnutrizione e una crescita della povertà estrema.
Terzo anello – Erosione della legittimità governativa: In Stati con capacità istituzionali deboli e risorse fiscali limitate, i governi faticano a rispondere efficacemente a shock climatici ed economici. L’incapacità di fornire assistenza adeguata viene percepita come fallimento fondamentale, erodendo la legittimità del governo.
Quarto anello – Tensioni sociali acute: L’erosione della legittimità statale e il deterioramento delle condizioni economiche generano dinamiche problematiche: movimenti migratori significativi, pressione su infrastrutture urbane, risentimento verso gruppi percepiti come avvantaggiati, proteste e disordini civili più frequenti.
Quinto anello – Escalation verso violenza: In contesti caratterizzati da istituzioni statali deboli, divisioni etniche o religiose profonde, e disponibilità di armi, le tensioni sociali ed economiche possono degenerare in criminalità diffusa, scontri tra comunità, insurrezioni o conflitti armati organizzati.

Il Caso Paradigmatico: La Siria
Un esempio concreto di come questa catena causale operi è fornito dalla Siria. La siccità eccezionale che ha colpito il Paese tra il 2006 e il 2010, identificata come la peggiore in novecento anni di storia documentata, ha avuto conseguenze devastanti e concatenate:
- Fallimenti diffusi dei raccolti nelle aree rurali
- Circa 1,5 milioni di persone migrate dalle aree rurali verso le periferie delle grandi città
- Creazione di enormi insediamenti informali con disoccupazione dilagante e povertà estrema
- Risposta governativa inadeguata che ha eroso ulteriormente la legittimità del regime
- Escalation rapida verso la guerra civile quando le proteste della Primavera Araba hanno raggiunto il Paese nel 2011
Il Mediterraneo: Laboratorio Vivente del Futuro Climatico
Il Nuovo Patto per il Mediterraneo, presentato contestualmente alla Vision globale nell’ottobre 2025, affronta una regione che l’Intergovernmental Panel on Climate Change ha identificato esplicitamente come uno degli hotspot climatici più critici dell’intero pianeta.
Il Mediterraneo non è semplicemente una regione che subirà impatti climatici tra molte altre, ma è un’area dove il riscaldamento sta procedendo a un ritmo significativamente superiore alla media globale e dove gli impatti sono già tangibili, misurabili e in molti casi devastanti per ecosistemi, economie e società.
Climate-Security Nexus: Il Riscaldamento Accelerato del Mediterraneo
Le temperature medie annuali nel bacino del Mediterraneo hanno già superato i livelli preindustriali di 1,5°C, una soglia che l’Accordo di Parigi aveva fissato come obiettivo globale da non superare entro fine secolo. La regione mediterranea ha già superato questa soglia con quattro decimi di grado di margine rispetto alla media globale.
Gli Impatti Interconnessi
Questa accelerazione del riscaldamento si traduce in una cascata di impatti interconnessi che stanno già trasformando profondamente la regione:
- Le precipitazioni estive stanno diminuendo fino al 20-30% in alcune aree
- La variabilità interannuale delle precipitazioni sta aumentando
- Gli eventi di siccità si stanno intensificando drammaticamente
- Le ondate di calore aumentano in frequenza, intensità e durata
- Il rischio di incendi boschivi è aumentato in modo esponenziale
- Le falde acquifere costiere subiscono processi di salinizzazione progressiva
- Gli ecosistemi mediterranei stanno perdendo specie a un ritmo allarmante
Climate-Security Nexus: L’Intersezione con Multiple Crisi Geopolitiche
La complessità della situazione mediterranea è amplificata drammaticamente dal fatto che la regione si trova all’intersezione di multiple crisi geopolitiche:
- Le guerre devastanti in Siria e Libia hanno generato massicce ondate migratorie
- Il conflitto israelo-palestinese continua a generare tensioni regionali acute
- L’instabilità cronica nel Sahel si riversa progressivamente verso nord
- Le tensioni tra Turchia e vari Paesi della regione aggiungono ulteriore complessità
- La competizione tra potenze esterne crea dinamiche di frammentazione
L’Architettura del Climate-Security Nexus
Il Patto per il Mediterraneo include oltre cento progetti concreti strutturati attorno a tre pilastri fondamentali che riflettono una comprensione matura e olistica della sfida.
Primo Pilastro: Le Persone
Si concentra sul capitale umano, riconoscendo che la stabilità di lungo periodo richiede investimento nelle persone. Include:
- Cooperazione su migrazione regolare e mobilità giovanile
- Dialogo interculturale e comprensione reciproca
- Supporto alla società civile e organizzazioni di base
- Programmi educativi e formazione professionale
Secondo Pilastro: L’Economia
Parte dal presupposto che la stabilità richiede opportunità economiche concrete. Gli elementi centrali includono:
- Partnership energetiche per la transizione verde come nucleo centrale
- Investimenti in infrastrutture sostenibili e resilienti
- Sviluppo di catene del valore regionali integrate
- Supporto all’imprenditorialità, specialmente giovanile e femminile
Terzo Pilastro: La Sicurezza
Riconosce che senza stabilità fisica né sviluppo né progresso sono sostenibili:
- Cooperazione su sicurezza marittima e controllo delle frontiere
- Contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata
- Gestione collaborativa delle crisi e meccanismi di early warning
- Rafforzamento delle capacità istituzionali di sicurezza
L’Energia come Perno Strategico
La dimensione energetica è esplicitamente posizionata al centro come perno che connette i tre pilastri. La transizione energetica può simultaneamente:
- Creare occupazione qualificata e opportunità economiche
- Stabilizzare economie fragili attraverso investimenti strutturali
- Ridurre tensioni legate alla scarsità di risorse energetiche
- Costruire interdipendenze positive che disincentivano conflitti
Le Sfide dell’Implementazione
Tradurre questa architettura ambiziosa in risultati concreti sul terreno richiede affrontare sfide formidabili:
- Frammentazione politica: la regione è caratterizzata da relazioni bilaterali spesso tese e mancanza di istituzioni regionali forti
- Asimmetrie di potere: le differenze economiche e politiche tra sponde nord e sud del Mediterraneo creano diffidenza
- Competizione geopolitica: attori esterni perseguono agende proprie che possono contraddire la cooperazione regionale
- Deficit di fiducia: decenni di promesse non mantenute hanno creato scetticismo verso nuove iniziative europee
- Capacità di assorbimento limitate: molti Paesi partner mancano delle capacità istituzionali e tecniche per implementare progetti complessi
Climate-Security Nexus: Il Test Cruciale
Il Mediterraneo emerge come test cruciale della validità dell’approccio integrato europeo che lega clima, sicurezza e sviluppo in un framework coerente. Se l’Europa riuscirà a catalizzare una transizione che stabilizzi la regione, crei prosperità condivisa e riduca tensioni strutturali, dimostrerà la validità e la replicabilità del suo modello di diplomazia climatica.
Se fallirà, confermerà invece la tesi pessimista che la cooperazione climatica significativa è impossibile in contesti caratterizzati da frammentazione geopolitica profonda, interessi divergenti e deficit di fiducia cronici.
Implicazioni Globali
La posta in gioco trascende di gran lunga la regione mediterranea. Il successo nel Mediterraneo potrebbe fornire un modello replicabile per altre aree del mondo dove clima e sicurezza si intersecano in modo esplosivo:
- Il Sahel, dove desertificazione e terrorismo si alimentano reciprocamente
- L’Asia centrale, dove competizione per acqua attraversa confini nazionali
- I piccoli stati insulari, minacciati esistenzialmente dall’innalzamento del mare
- Le megacittà costiere vulnerabili in Asia e Africa
Questi contesti critici guarderanno tutti all’esperienza mediterranea per trarre lezioni su cosa funziona e cosa non funziona nella gestione cooperativa della convergenza tra crisi climatica e instabilità geopolitica. Il Mediterraneo non è semplicemente una regione da stabilizzare, ma un laboratorio dove si sta testando in tempo reale se è possibile costruire cooperazione significativa su clima e energia in contesti frammentati.
Il verdetto su questo esperimento determinerà non solo il futuro del Mediterraneo, ma anche la credibilità dell’intero approccio europeo alla diplomazia climatica e la possibilità stessa di affrontare cooperativamente il cambiamento climatico in un mondo multipolare e competitivo.
Fonti e Approfondimenti
- IPCC – Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability
- Climate Centre – Climate Security Resources
- UN Security Council – Climate and Security
- Commissione Europea – Climate Change in the Mediterranean
- Union for the Mediterranean – Partnership and Cooperation
- Clingendael Institute – Climate Security Nexus Analysis
- NATO – Climate Change and Security
Vuoi approfondire il legame tra sicurezza e clima? Scopri le nostre aree di specializzazione